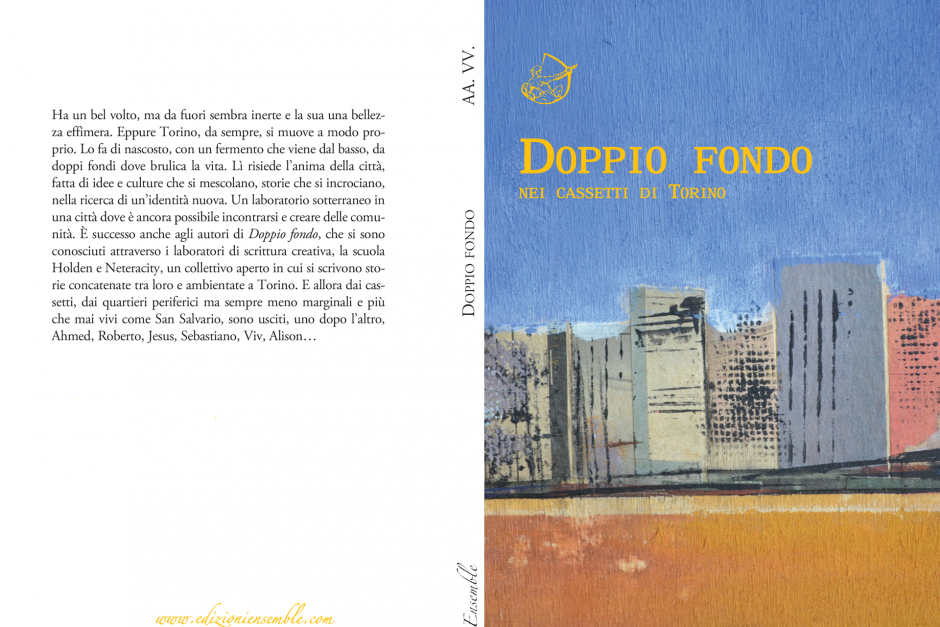Mi sono svegliato questa mattina con la netta sensazione di essere morto. Tutto intorno sembrava di un altro mondo, staccato da me. Eppure avvertivo forte il calore da insofferenza per le coperte, quello che mi dà ogni giorno la certezza di avere superato il limite massimo di ore che sono in grado di passare a letto.
E sono riuscito a raggiungere il tavolo, a bermi il solito caffelatte. Ma quel vestito, appeso al portabiti, chi lo ha mai visto?
Un vestito gessato, lucido, perfettamente stirato, direi nuovo, anzi, sicuramente è così. Se avessi avuto prima una giacca del genere me ne ricorderei. Non sono il tipo io. Jeans e maglietta, quello sì. E poi, chi ce lo ha messo lì?
La chiave gira nella toppa.
− Alessandro? − chiamano dall’ingresso.
È mia madre. Ha ricominciato a entrarmi in casa senza avvertire.
Ora non mi trova, o trova il mio corpo esanime nelle coperte.
− Tieni, era nella buca − mi fa quando mi vede. Perché pare proprio che mi veda.
E adesso mi ritira anche la posta. Be’, perlomeno non mi sta camminando attraverso. Il biglietto, quando me lo passa, mi finisce nella mano, non per terra. Non è imbustato, è un foglio di carta giallina spiegazzata. Su un angolo c’è scritto “per Ale” a penna blu e a lettere tremolanti come se non avessero trovato nessun appoggio solido e liscio.
Non mi piacciono i biglietti, sono sempre scocciature anche quando sono belli. Ma lo apro, anche se di malavoglia. Tanto peggio di così non può andare. La frase all’interno recita: “Amico mio, da oggi sei ufficialmente morto”.
− Mamma. Mamma leggi qui. Mi spieghi cosa sta succedendo?
Mia madre lo esamina con il suo solito fare pratico, con gesti rapidi e sbrigativi.
− Alessandro, che cosa vuoi che ti dica… se c’è scritto così, sarà vero. Vatti a vestire, o qui si fa tardi. Hai tutto quello che ti serve?
A saperlo, che cosa serve a un morto! Certo, una comunicazione del genere dovrebbe arrivare debitamente dattiloscritta, e anche vidimata in modo adeguato. Mi sembrerebbe il minimo.
E siccome ho questo cerchio alla testa che non mi lascia, e tutto sembra lontanissimo, non ho la forza di controbattere. Alla fine indosso la mia rassegnazione poco lucida insieme al vestito perfettamente stirato e nuovo.
− Hai ragione, meglio che ci avviamo solo tu e io − dice mia madre tenendomi a braccetto mentre mi trascina in strada, al centro della carreggiata. Sprezzante del pericolo, come se oggi fosse tutto lecito. O come se non ci fosse più niente da perdere.
− È più intimo e ci prepara meglio alla tua grande giornata. Vorrei dirti così tante cose, ma non so da dove cominciare! Facciamo così, non dirò nulla, in fondo sei un ragazzo maturo e io sono molto fiera di te, sono certa che sai già tutto quello che occorre.
L’abito scuro le dona. I capelli, che hanno da tempo scordato il nero, odorano di chiesa e di messa della domenica. La sua mano sulla mia spalla si divide da sempre in tante brevi pacche vicine che sembra ripetano a ritmo “Sono qui ragazzo mio, sono qui, sono qui…”.
Anche oggi, senza lei accanto, non so come farei.
− Ma tu non mi ascolti! Cos’è quella faccia? E dai, andrà tutto bene!
Davanti alla chiesa la psicosi collettiva sembra aver preso il sopravvento. Sono un centinaio, tra amici e parenti. Le strette di mano, a cui non ho la forza di reagire, le percepisco appena. Sono tutti eleganti, proprio come richiede un funerale. Eppure sorridono. Certo, non sono uno stinco di santo, ma da qui a godere della mia morte!
Poi, finalmente, uno sguardo preoccupato mi si fa incontro. È Dario, lo riconosco, il mio amico di sempre. Anche se oggi mi sembra più basso del solito, e i suoi occhi meno azzurri. Mi si av- vicina, mi afferra un braccio all’altezza del gomito tirandomi un po’ da parte. Mi trascina quasi, fino al lato destro della chiesa, l’ingresso del campanile.
− Ehi amico, ieri notte abbiamo esagerato. Non dovevamo montarti in quel modo. Non avresti mai dovuto tornare a casa da solo in quello stato. È colpa mia, è colpa mia.
E intanto mi spalanca l’occhio tra il suo pollice e l’indice, av- vicina la sua faccia alla mia, finché io mi tiro indietro infastidito.
− Ho provato a chiamarti mille volte, e ogni volta che non ri- spondevi mi cresceva il senso di colpa.
Di cosa diavolo sta parlando?
− Aspetta qui Ale, ho una roba che ti rimette in piedi, ti tira su almeno per la giornata, te la vado a prendere in macchina. Non ti muovere − mi fa con la mano appoggiata sul mio petto.
Il suono delle campane mi stordisce ogni intenzione di seguire Dario. Sotto quel suono, poi, ce n’è un altro: sembrano grida, grida tremende che fanno male. Vengono dall’alto, dalla cima della scala alle mie spalle.
L’istinto risponde per me, ma mentre salgo i gradini, le gambe mi pesano come il piombo.
Poi mi fermo, tiro il fiato dopo l’ultimo gradino. Ma quando sollevo la testa, la scena che ho davanti me lo toglie di nuovo.
Il campanaro ha un piede incastrato nella corda che agita la campana. È appeso a testa in giù e a ogni colpo del pendolo di ferro sulle pareti della campana, corrispondono una sonora testata di lui contro il pavimento legnoso e un grido lancinante.
A chiamare aiuto non ci riesco, ho la bocca secca. E da sotto nessuno sembra accorgersi di niente. Sarebbero già saliti altrimenti. Mi porto le mani davanti alla faccia, strofino forte gli occhi. Anche questo adesso? Che cosa manca a una giornata così?
E tutto sommato, in fondo è divertente. Sì, è divertente. Lui si agita talmente che la corda, oltre a essersi impigliata attorno al piede, gli stringe il ventre in una cintura impietosa che divide e fa ballonzolare due rotoli molli perfettamente simmetrici. Qualche goccia di sudore sulla fronte si confonde con i rivoli di sangue che incorniciano il viso paonazzo. Ah, il vecchio campanaro è un grande esperto di Barbera, in parrocchia è un fatto noto! Muove le braccia velocemente, dal basso verso l’alto, come se volesse prendere il volo.
− Calmati vecchio − mi esce di bocca. − Ti prenderà un accidente se continui ad agitarti così!
In che razza di posto mi hanno portato. Qui, alla base di questo campanile dall’aspetto irrequieto e dal taglio austero, ci seppellivano i boia. È tutto detto. E non merita nemmeno il nome di Sant’Agostino visto che se ne sta per conto suo, separato dall’edificio principale, da cui è diverso per colore e materiale. Un intruso goffo dietro al volto principale della chiesa.
Anche io mi sento fuori posto oggi. Lontano da tutto, tutto lontano da me. Dovrei limitarmi a scendere le scale e tornare dagli altri che mi aspettano, finire quello per cui mi hanno portato qui, e togliermi da questo posto senza anima.
Mi siedo a terra, schiena contro il muro e gomiti accomodati sulle ginocchia piegate. Chino il capo un istante per accendermi una sigaretta, e quando lo sollevo di nuovo, davanti a me c’è un prete. Mi osserva con gli occhi stretti da miope che non porta gli occhiali. Ha radi capelli bianchi e una faccia larga e amichevole. Del campanaro nessuna traccia, le campane non suonano più.
− Figliolo, non avrai cambiato idea! − ha la voce indulgente di un nonno. − La sposa è arrivata da un pezzo.