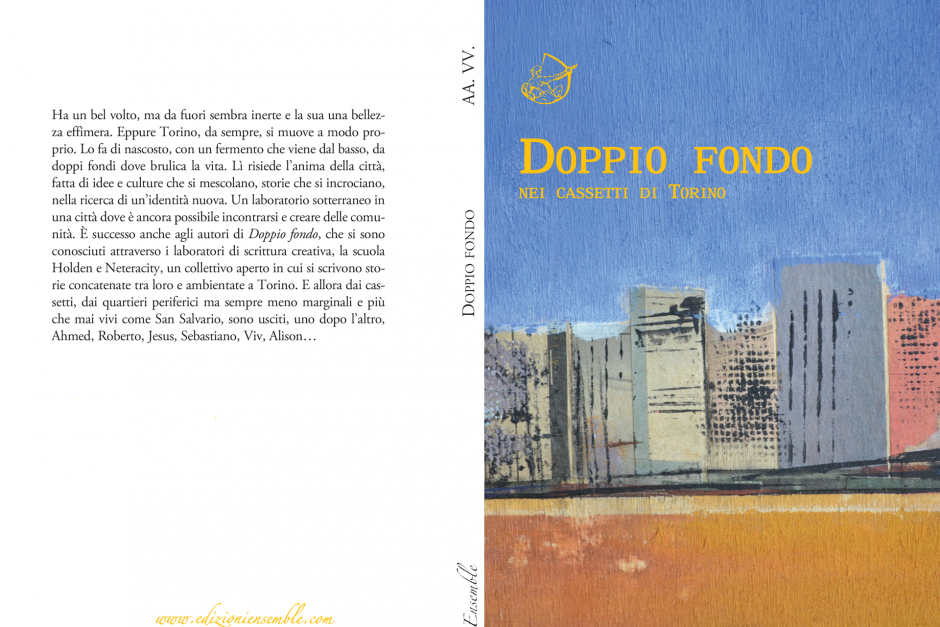Stavo pensando se tutti siano stati bene in viaggio.
Se sia piaciuto al signore con gli occhialini che mi ripeteva sempre -milleecento di pensione io-cinquecento mia moglie-il figlio-che ha due bimbi e non lavora. Sai Chiara, mia moglie si è operata al cuore, mica possiamo fare tutto.
E la cicatrice prima io non l’avevo sentita, dopo non potevo fare a meno di fissarla, ogni volta, partire esatta da sotto al collo e spiegarmi lo sterno.
Se sia stata bene Cesarina, per cui bisognava far cucinare in bianco, senza sale, senza verdure, senza pomodoro. Senza cucinare.
Parlava con le altre persone come se afflitta da un costante senso di vertigine, piegandosi delicatamente in avanti come a cacciare la testa fuori dalla sua membrana personale, col timore di essere scoperta, tenendo gli occhi apertissimi.
Anna, ex presidente del gruppo anziani era nativa di Cipro. Ha passato il testimone, ma conserva molti consigli severi da imporre. Carichiamo prima le valigie, facciamo colazione presto, qualcuno chiuda il gruppo.
E poi la trovo spaesata nell’unica rampa di scale tra la reception e la sala colazione, che mi chiede con la cz pizzicata greca se sapessi dove trovare un tovagliolo per pulirczi i baffi.
Alcuni sono andati via senza neanche salutarmi, altri mi hanno baciata e abbracciata. Una signora mi ha stretta forte e ha insistito per infilarmi in tasca tutte le monete che le erano rimaste, perché era stato il viaggio più bello.
Vorrei aver vissuto tutte le loro vite, sapere come diavolo ha fatto la signora Giulia a farsi regalare dal marito, un maestoso burbero, la fede sarda per i cinquantacinque-mila- (credo) anni di matrimonio festeggiati in viaggio.
Quali parole sono state bugie, quali smorfie, quale il loro ruolo più difficile, quale contentezza.
Da cosa si son dovuti mettere a riparo, quali incontri hanno cambiato ogni cosa, quali poesie d’amore avrebbero voluto scrivere.
La vita si manifesta in mille modi possibili. Impossibile è non reagire.
Nel paese di Mussumeli c’è un castello.
Il castello del paese di Mussumeli poggia sulla roccia.
A Mussumeli vive da sempre Maria. Quando la voce che stava per nascere un bambino cominciava a rimbalzare tra le porte del paese, Maria spennava una gallina. Sessantacinque colli tirati per festeggiare la vita. E Maria arrivava anche se la voce si infilava a fatica tra le imposte, quando erano serrate dal dolore.
Prega spesso Maria, ha confidenza con il rosario, e la sensazione di premere cinquanta volte una tonda vergine speranza tra i polpastrelli, si ferma più a lungo del dovuto nelle mani, che, ormai abituate, tornano sempre a rifugiarsi l’una nell’altra, come sanno. Le sue dita, ora, non stanno mai completamente distese, quando accompagnano le parole, andando in cerca di attenzione, prendono un ritmo orizzontale e deciso, come a disegnare il tono della voce.
Se Maria stringe il pugno, i nodi sulle nocche si devono spartire un profilo che si è fatto troppo stretto per restare regolare. Viene facile immaginare quelle mani che facevano la guerra ai panni, addomesticando un sapone di quelli scomodi, rettangolari e grandi, oppure mentre si destreggiano, ancora del tutto a proprio agio, nella farina, firmando con semi di papavero e sesamo, il pane che nessuno in famiglia è ancora riuscito ad imparare a fare uguale.
Maria si è sposata sessantanove anni fa, quando aveva ventuno anni.
Di quel giorno custodisce due foto, una sulle scale della chiesa di Mussumeli, l’altra nella Piazza Grande. Conserva al dito anche la fede che per sessantacinque anni ha seguito i gesti di suo marito, le sta un po’ grande, è fermata sul davanti dalla sua, che la lascia muoversi comoda, ma senza allontanarsi mai.
Le mani di Maria hanno accarezzato la testa di quattro figli, otto nipoti, e quattro pronipoti.
Una delle sue figlie si chiama Maria anche lei, Maria la piccola. Lei sta seduta composta, ti guarda dritto in faccia, e scandisce bene le parole, dando loro un posto preciso. Sembrano molto diverse, ma il momento in cui gli occhi si schiudono nella stessa melodia rimane impresso. Hanno in comune la speranza, e il dono di dimenticare. In una vita non ci sono giorni che ritornano, né sguardi tali e quali, ma quando i sorrisi di mamma e figlia si tengono fra le braccia si crea un’armonia. Sono diversi, come due gocce d’acqua.
Maria ha una nipote, si chiama Caterina. Una notte Caterina ha dovuto fermare la nonna mentre correva sul letto inseguendo una gallina. Una impudente gallina, che aveva disturbato il suo sogno cercando di rubarle i biscotti. Doveva essere punita.
Vederle vicine fa venire voglia di felicità, la pelle è nota alle pelle, e le loro teste sono piene di libertà e di quella leggerezza vigile, che ha il potere di rendere unica ogni piccola cosa.
A Natale Maria, Maria e Caterina cucinano insieme, preparano i biscotti e li ornano seguendo un disegno: quello del pizzicatore, costruito dal marito di Maria apposta per lei, che ricama autorevole la sua sigla.
In queste occasioni anche le risate possono scoprire di non sapere più riconoscersi per quanto si assomigliano.
Si racconta dei venti alberi di fichi piantati dal padre per la passione di Maria la piccola, dello zoccolo preso in faccia quella volta che i vicini stavano litigando, o del fuoco acceso di nascosto per togliere di mezzo tutto quello che era seccato.
Anche le pene volgono in riso, e i pensieri di gioia assolvono per qualche tempo i lunghi ricordi tristi.
Il mondo che si crea tra loro non è ovvio per niente, ma un’occasione unica, la cui atmosfera non può essere dipinta, né raccontata da magnifici paragoni. Una verità straordinaria, a cui però non si può fare a meno di prestare attenzione.
Tutto è accaduto tempo fa, ed è accaduto ieri.
Mi sono svegliato questa mattina con la netta sensazione di essere morto. Tutto intorno sembrava di un altro mondo, staccato da me. Eppure avvertivo forte il calore da insofferenza per le coperte, quello che mi dà ogni giorno la certezza di avere superato il limite massimo di ore che sono in grado di passare a letto.
E sono riuscito a raggiungere il tavolo, a bermi il solito caffelatte. Ma quel vestito, appeso al portabiti, chi lo ha mai visto?
Un vestito gessato, lucido, perfettamente stirato, direi nuovo, anzi, sicuramente è così. Se avessi avuto prima una giacca del genere me ne ricorderei. Non sono il tipo io. Jeans e maglietta, quello sì. E poi, chi ce lo ha messo lì?
La chiave gira nella toppa.
− Alessandro? − chiamano dall’ingresso.
È mia madre. Ha ricominciato a entrarmi in casa senza avvertire.
Ora non mi trova, o trova il mio corpo esanime nelle coperte.
− Tieni, era nella buca − mi fa quando mi vede. Perché pare proprio che mi veda.
E adesso mi ritira anche la posta. Be’, perlomeno non mi sta camminando attraverso. Il biglietto, quando me lo passa, mi finisce nella mano, non per terra. Non è imbustato, è un foglio di carta giallina spiegazzata. Su un angolo c’è scritto “per Ale” a penna blu e a lettere tremolanti come se non avessero trovato nessun appoggio solido e liscio.
Non mi piacciono i biglietti, sono sempre scocciature anche quando sono belli. Ma lo apro, anche se di malavoglia. Tanto peggio di così non può andare. La frase all’interno recita: “Amico mio, da oggi sei ufficialmente morto”.
− Mamma. Mamma leggi qui. Mi spieghi cosa sta succedendo?
Mia madre lo esamina con il suo solito fare pratico, con gesti rapidi e sbrigativi.
− Alessandro, che cosa vuoi che ti dica… se c’è scritto così, sarà vero. Vatti a vestire, o qui si fa tardi. Hai tutto quello che ti serve?
A saperlo, che cosa serve a un morto! Certo, una comunicazione del genere dovrebbe arrivare debitamente dattiloscritta, e anche vidimata in modo adeguato. Mi sembrerebbe il minimo.
E siccome ho questo cerchio alla testa che non mi lascia, e tutto sembra lontanissimo, non ho la forza di controbattere. Alla fine indosso la mia rassegnazione poco lucida insieme al vestito perfettamente stirato e nuovo.
− Hai ragione, meglio che ci avviamo solo tu e io − dice mia madre tenendomi a braccetto mentre mi trascina in strada, al centro della carreggiata. Sprezzante del pericolo, come se oggi fosse tutto lecito. O come se non ci fosse più niente da perdere.
− È più intimo e ci prepara meglio alla tua grande giornata. Vorrei dirti così tante cose, ma non so da dove cominciare! Facciamo così, non dirò nulla, in fondo sei un ragazzo maturo e io sono molto fiera di te, sono certa che sai già tutto quello che occorre.
L’abito scuro le dona. I capelli, che hanno da tempo scordato il nero, odorano di chiesa e di messa della domenica. La sua mano sulla mia spalla si divide da sempre in tante brevi pacche vicine che sembra ripetano a ritmo “Sono qui ragazzo mio, sono qui, sono qui…”.
Anche oggi, senza lei accanto, non so come farei.
− Ma tu non mi ascolti! Cos’è quella faccia? E dai, andrà tutto bene!
Davanti alla chiesa la psicosi collettiva sembra aver preso il sopravvento. Sono un centinaio, tra amici e parenti. Le strette di mano, a cui non ho la forza di reagire, le percepisco appena. Sono tutti eleganti, proprio come richiede un funerale. Eppure sorridono. Certo, non sono uno stinco di santo, ma da qui a godere della mia morte!
Poi, finalmente, uno sguardo preoccupato mi si fa incontro. È Dario, lo riconosco, il mio amico di sempre. Anche se oggi mi sembra più basso del solito, e i suoi occhi meno azzurri. Mi si av- vicina, mi afferra un braccio all’altezza del gomito tirandomi un po’ da parte. Mi trascina quasi, fino al lato destro della chiesa, l’ingresso del campanile.
− Ehi amico, ieri notte abbiamo esagerato. Non dovevamo montarti in quel modo. Non avresti mai dovuto tornare a casa da solo in quello stato. È colpa mia, è colpa mia.
E intanto mi spalanca l’occhio tra il suo pollice e l’indice, av- vicina la sua faccia alla mia, finché io mi tiro indietro infastidito.
− Ho provato a chiamarti mille volte, e ogni volta che non ri- spondevi mi cresceva il senso di colpa.
Di cosa diavolo sta parlando?
− Aspetta qui Ale, ho una roba che ti rimette in piedi, ti tira su almeno per la giornata, te la vado a prendere in macchina. Non ti muovere − mi fa con la mano appoggiata sul mio petto.
Il suono delle campane mi stordisce ogni intenzione di seguire Dario. Sotto quel suono, poi, ce n’è un altro: sembrano grida, grida tremende che fanno male. Vengono dall’alto, dalla cima della scala alle mie spalle.
L’istinto risponde per me, ma mentre salgo i gradini, le gambe mi pesano come il piombo.
Poi mi fermo, tiro il fiato dopo l’ultimo gradino. Ma quando sollevo la testa, la scena che ho davanti me lo toglie di nuovo.
Il campanaro ha un piede incastrato nella corda che agita la campana. È appeso a testa in giù e a ogni colpo del pendolo di ferro sulle pareti della campana, corrispondono una sonora testata di lui contro il pavimento legnoso e un grido lancinante.
A chiamare aiuto non ci riesco, ho la bocca secca. E da sotto nessuno sembra accorgersi di niente. Sarebbero già saliti altrimenti. Mi porto le mani davanti alla faccia, strofino forte gli occhi. Anche questo adesso? Che cosa manca a una giornata così?
E tutto sommato, in fondo è divertente. Sì, è divertente. Lui si agita talmente che la corda, oltre a essersi impigliata attorno al piede, gli stringe il ventre in una cintura impietosa che divide e fa ballonzolare due rotoli molli perfettamente simmetrici. Qualche goccia di sudore sulla fronte si confonde con i rivoli di sangue che incorniciano il viso paonazzo. Ah, il vecchio campanaro è un grande esperto di Barbera, in parrocchia è un fatto noto! Muove le braccia velocemente, dal basso verso l’alto, come se volesse prendere il volo.
− Calmati vecchio − mi esce di bocca. − Ti prenderà un accidente se continui ad agitarti così!
In che razza di posto mi hanno portato. Qui, alla base di questo campanile dall’aspetto irrequieto e dal taglio austero, ci seppellivano i boia. È tutto detto. E non merita nemmeno il nome di Sant’Agostino visto che se ne sta per conto suo, separato dall’edificio principale, da cui è diverso per colore e materiale. Un intruso goffo dietro al volto principale della chiesa.
Anche io mi sento fuori posto oggi. Lontano da tutto, tutto lontano da me. Dovrei limitarmi a scendere le scale e tornare dagli altri che mi aspettano, finire quello per cui mi hanno portato qui, e togliermi da questo posto senza anima.
Mi siedo a terra, schiena contro il muro e gomiti accomodati sulle ginocchia piegate. Chino il capo un istante per accendermi una sigaretta, e quando lo sollevo di nuovo, davanti a me c’è un prete. Mi osserva con gli occhi stretti da miope che non porta gli occhiali. Ha radi capelli bianchi e una faccia larga e amichevole. Del campanaro nessuna traccia, le campane non suonano più.
− Figliolo, non avrai cambiato idea! − ha la voce indulgente di un nonno. − La sposa è arrivata da un pezzo.
Forse l’abito è giallo o magari rosa. Sicuramente il tessuto è spesso e lucido, a giudicare dalle pieghe determinate e dal fiocco immobile al centro del petto.
Il vestito della persona che le è accanto, con cui spesso viene confusa, è spezzato in due, ma la lunghezza della gonna è identica, taglia le gambe esattamente nello stesso punto, poco sopra la caviglia.
Certamente tutto proviene da un unico guardaroba, in cui ogni cosa può essere scambiata. L’altra gonna è morbida, fitta di minuscole pieghe verticali. Una fascia larga e una balza decorata si alternano per due volte, per terminare con una blusa nera che spegne le fantasie, e lascia spiccare solo un vistoso ciondolo d’oro giallo, a forma di sole, con la faccia disegnata da tratti spessi, rotondi, e l’espressione sorridente.
Le scarpe e le borsette sono repliche precise, non mostrano alcuna traccia di precedenti fughe domenicali dall’armadio, e anche la posizione dei piedi, il modo in cui le mani stringono le piccolissime bustine di pelle operata, fanno di tutto per assomigliarsi.
Arricciature corte e scure, ma soprattutto ben ordinate e immobili, disegnano gli stessi capelli, tirando al centro, o da un lato.
Le righe da cartolina sul retro della fotografia svelano la preparazione che è servita. Raccontano di una domenica speciale, di vestiti eleganti e nuovi, di un fotografo, di un fondale posticcio, di una foto ricordo da conservare nel cassetto, sotto la biancheria, oppure spedire, per riaccendere i visi nei ricordi di chi è lontano, e raccontargli come va.
Gli occhi delle ragazze, e le espressioni dei loro volti sembrano invece essere al corrente di cose diverse, non si assomigliano, sebbene siano composti da tratti pressoché identici.
Il viso sopra la camicetta scura è teso, ritto sul collo, mostra un contorno rigoroso, quasi squadrato, e sembra già pronto ad assumere troppe volte quell’espressione, con le labbra premute in orizzontale e lo sguardo fermo, ma triste.
La ragazza con l’abito chiaro offre alla macchina un profilo che si inclina volentieri fino allo sguardo di chi osserva, il capo è leggermente chino in avanti, gli occhi sembrano speranzosi e quasi sorridenti, se ci si sofferma a fissarli per più di qualche secondo.
Il suo braccio avvolge da dietro la sorella, le stringe il braccio. Forse è già pronta a sostenerla.
Ha la responsabilità di essere la maggiore, anche se, solo per una manciata di minuti.